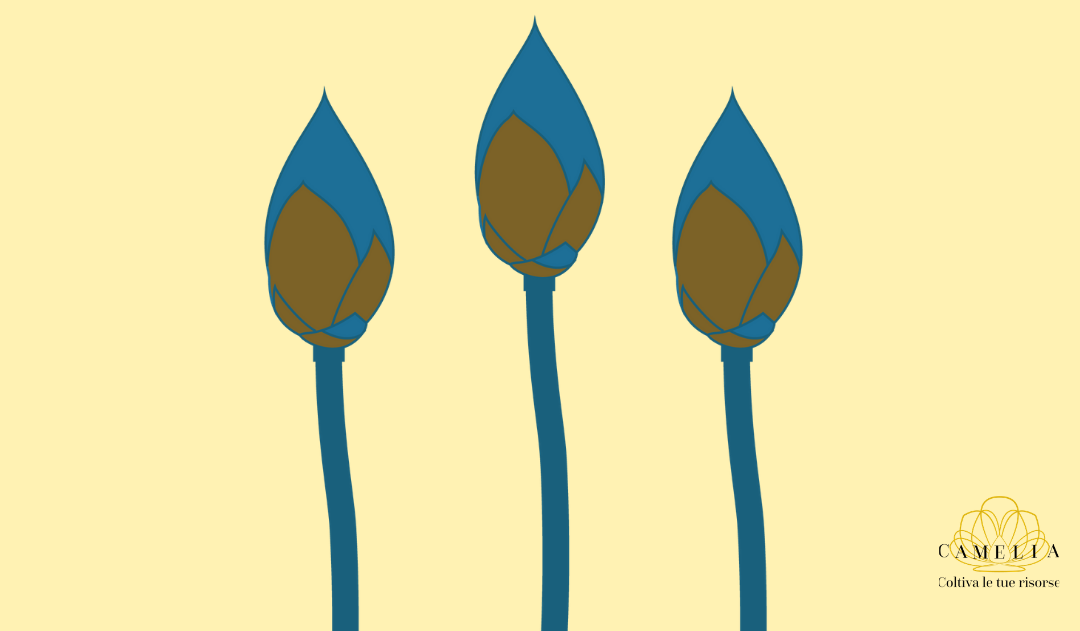La storia di ogni guerra è, anche, la storia di molte donne. Scorrendo indietro nel tempo mi vengono in mente le parigine che marciarono affamate su Versailles durante la Rivoluzione francese, per protestare contro i rincari del pane, e costrinsero il re a fare ritorno alle Tuileries; penso alle migliaia di donne che durante la Grande Guerra presero il posto di mariti, figli, fratelli nelle fabbriche, ottenendo in cambio che la produzione industriale non si fermasse, ma soprattutto una nuova idea di emancipazione e libertà, perfino nella moda (le gonne ampie e lunghe furono sostituite dai pantaloni, più pratici davanti ai macchinari e meno facili a impigliarsi).
E penso alle staffette partigiane durante la Resistenza, che trasportavano documenti e armi a rischio della propria vita, e hanno contribuito al pari degli uomini alla liberazione dal nazifascismo.
Ma gli esempi da raccontare sarebbero molti di più, se oggi la narrazione non fosse oscurata, e qualche volta sostituita, dalle immagini.
Le donne che vedo oggi, nella guerra che si combatte da poco più di un mese alle porte dell’Europa, sono in fuga, ferite, in lacrime. Immagini iconiche che tra pochi decenni troveranno spazio sui libri di scuola, accanto a quelle in bianco e nero di Robert Capa o di Nick Út. Immagini che spesso non hanno un nome, ma che non riusciamo a toglierci dalla testa, in una galleria fotografica di sofferenze che ci fa visita nei sogni.

C’è la giovane incinta nel suo pigiama a pois, che viene scortata fuori dall’ospedale di Mariupol colpito dai missili russi. Ha un’espressione quasi triste, incredula, e porta un sacco nero di plastica con le sue poche cose. Lei un nome ce l’ha: si chiama Marianna, e il dieci marzo ha partorito una bambina. Entrambe sono sopravvissute. Ma un’altra giovane donna incinta, che abbiamo visto portar via in barella, ferita all’addome, dallo stesso ospedale, non ce l’ha fatta; lei e il suo bambino sono morti poche ore dopo lo scatto di quella foto, troppo gravi le condizioni di entrambi.
C’è un’altra donna la cui immagine mi è rimasta impressa nell’anima: sguardo spento, passo lento, cammina lungo una strada col suo cane al guinzaglio, e ha due gatti che sbirciano fuori dal suo giaccone invernale, al riparo dal mondo. Fugge dalla sua città portandosi dietro quel che ha di più prezioso, e non si tratta di gioielli o beni di valore. L’unica cosa che insegna la guerra, quasi sempre, è a ridefinire le priorità, ma lo fa nel più doloroso dei modi.
E poi ci sono le donne che vanno in tv, nei talk show che troppo spesso sono feudi maschili, dove si deve alzare la voce per dire la propria: lo fa con piglio militaresco il vicepremier ucraino, Iryna Vereshchuk, e desta scalpore quando chiede le stesse cose che da settimane chiede Zelensky. Ma è donna, le sue esternazioni vengono soppesate con un metro di giudizio più severo. Ci sono le influencer russe e le giornaliste ucraine, quelle che sono rimaste in patria e quelle che vivono da anni all’estero perché a casa propria sarebbero o sono state vittime di purghe o censura; ci sono le nostre corrispondenti di guerra, che durante il tg della sera ci raccontano, alla luce fioca delle lampadine imposte dal coprifuoco e dall’oscuramento, quello che succede lassù. Ci sono i volti addolorati e impauriti delle donne anziane portate via in carrozzella o su carriole di fortuna dalle loro case bombardate, fatte salire su ambulanze o pullman, curate in ospedali per ferite del corpo e dell’anima: come Kateryna, a cui hanno amputato la gamba destra dal polpaccio in giù, e non sa come potrà tornare al lavoro dopo la guerra, ammesso che un lavoro a cui tornare ci sia ancora. E poi ci sono gli sguardi, un po’ meno infelici, di tutte quelle bambine e ragazze che ce l’hanno fatta a scappare, e ora sono ospiti di qualche paese che le accoglie, e magari offre loro la possibilità di una vita vagamente normale, quel tanto che basta per non impazzire del tutto.
Quando penso alla guerra penso, anche, a questi volti femminili; che combattono lungo un fronte tutto interiore, e scavano trincee non meno profonde di quelle dei soldati. Faglie che contengono corpi, oltre che ricordi e speranze, e separano nettamente il prima dal dopo, a partire da quel 24 febbraio 2022 in cui è iniziato, o finito, tutto.
Stefania Berti